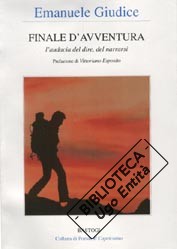|
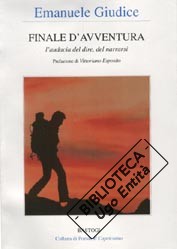
Intervento di Giovanni Occhipinti Problematicità e teologia della fede sono gli elementi fondanti del dialogo-monologo di “Finale d’avventura” di Emanuele Giudice. Ho avuto modo di seguire fin dal suo nascere la poesia di Emanuele Giudice e so per certo che il filo sottile che il poeta vittoriose va disvolgendo dal gomitolo-nucleo iniziale non ha subito interruzioni, ma si è anzi rafforzato in virtù di diverse e nuove diramazioni e direzioni prese nel tempo, il che equivale a dire che la sua poesia si è ulteriormente arricchita via via che egli ha potuto (saputo) com- piere le varie tappe del suo percorso di intellettuale, di scrittore e di poeta, E’ bene infatti ribadire che Emanuele non è soltanto un autore di poesia, ma l’autore che vive, in tutta la sua complessità, la condizione intellettuale del poligrafo, muovendosi con disinvoltura nell’ambito delle diverse aree della scrittura: la saggistica, la narrativa, la poesia. Un autore, dunque, alle prese con temi e motivi desunti dalle grandi problematiche che da sempre assillano l’uomo della terra. Ebbene, egli le affronta anche da narratore e da “analista” politico. Ne segue che una trama profonda, complessa, sofferta di meditazioni-riflessioni, organizza, modula, sviluppa in grandi temi esistenziali e teo-filosofici la sua poetica e il suo ‘poiein’, il suo far poesia. Questo, quanto mi suggerisce la lettura della recente silloge poetica: “Finale d’avventura” (Bastogi, 2006).
Riflettiamo: “finale d’avventura”, non “fine d’av- ventura” o “fine dell’avventura” o di un’avventura, una qualsiasi avventura! Nel sintagma che dà il titolo al libro è racchiuso il destino umano e sopranna- turale dell’uomo, la sua conclusione, l’epilogo terreno, che nell’escatologia cristiana coincide con l’Eterno. Bene, da questo momento bisognerà di- stricarsi tra questi concetti, quasi coordinate entro cui individuare e definire il discorso di Emanuele Giudice, che attinge da una materia calda ma fluida e difficile e sfuggente, quella eterna, che ama i percorsi talora tortuosi e con qualche immersione negli anfratti, nelle cavità ctonie, negandosi alla luce del pensiero del povero cristiano, ma che tuttavia ha il vantaggio dei grandi dilemmi, alimentandosi alle connessioni con la teologia della fede e soprattutto della sua problematicità e complessità. Non è infatti facile andare per i luoghi della trascendenza attra- verso percorsi metafisici, specie in poesia. Giudice ci prova anche a costo di dover trasferire motivi e temi anche di sua materia saggistica e saggistico-biblica nella struttura del testo poetico, per costruire là il luogo scomodo e spinoso dei suoi interrogativi; e a dispetto, direi, della stessa fede, dei rovelli e crucci propri di colui che crede, ma con l’ansia di chi sa, quasimodianamente, che alla ferita e trafittura del “raggio di sole” – l’abbaglio della vita, il segno tangibile che si è vivi – subito segue “la sera”, altro topos quasimodiano, sulla terra, cioè la contrazione dell’essere e dell’esistenza, ovvero il “finale d’av- ventura”. Sul dorso, sul groppone di questa parabola si soffre lo sconforto dello smarrimento e della solitudine. Ricomponiamo allora i versi di Ed è subito sera: “Ognuno sta solo sul cuor della terra / trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera”. Ebbene, Giudice è assai vicino a certi scottanti temi del poeta di Modica; mi riferisco al Quasimodo lettore laico della Bibbia; al contario, il Nostro è lettore di fede e qualche volta esegeta della pagina biblica; questo vuol dire che le sue riflessioni sono da lettore sulle spine, perché è chiaro che non tutto del grande libro è metabolizzabile, né immediata- mente, né a lungo o lunghissimo termine. Ecco allora che il travaglio esistenziale dell’uomo di fede fa i conti anche con la parola-parabola poetica, la sua, che non discopre, come quella biblica, ma vela le sue “verità”, quelle dentro di noi, che appartengono alla nuda umanità, nel bene e nel male, negandoci la propria essenza e sovrastandoci imbozzolate nel falso abito bene agghindato del dubbio, fino a quando, finalmente, si disgelano schiudendosi al “finale d’avventura”. Dal prologo all’epilogo di sviluppa un miserabile e grande segmento d’esi- stenza (quando entrano in giuoco gli ossimori si sta parlando di vita!) che aspira alla Verità mosso da una imperfetta tensione dell’Altro. E’ questo il magma che ribolle nel pensiero poetico di Giudice, è questo il magma che incendia e tormenta tutta quanta la sua poesia, per la cui comprensione dovremmo almeno rivedere alcuni fondamentali poeti europei, a partire da La terra desolata di Eliot.
Altro aspetto, ma complementare alla ricerca di Giudice, è l’approccio assolutamente umano con il concetto agostiniano di tempo, nel senso che la sua essenza diviene mistero quando lo si confronti con l’eternità: “Se nessuno me lo domanda – confessava Agostino – lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo domanda non lo so”. Ebbene, si legga in questo senso Elegia del tempo: “Come fai / a dire ora / se mentre lo dici / tra le mani ti si spappola / il senso / e ora è già non ora” (c’è perfino la cadenza e il ritmo interroganti di Agostino in questi versi). E’ Dio che contiene il tempo, e il tempo l’uomo, il cui destino è vivere il “finale d’avventura” nell’azzeramento terreno della morte che, in quanto tale, finisce di essere il tempo dell’uomo per farsi il Tempo di Dio. La morte si fa dunque tempo metafisico, Spazio extra- temporale, Dopo-escatologico e cioè mistero per la terra (si legga il componimento La lentezza. Possiamo allora meglio comprendere l’andamento monologante di questa poesia di Emanuele. Un monologo che si dilata e si verticalizza su punti nevralgici dell’esistenza-oltre, via via approfondendo la condizione dell’attesa e del soffrire dell’uomo della terra.
Voglio permettermi una nota, in parentesi, per una rapida osservazione che potremmo definire tecnica: trovo che la struttura dei testi, apparentemente tra loro differenziati dai titoli, è invece naturalmente un tutt’uno poematico, proprio perché tra loro apparen- tabili le immagini, l’attesa, le tensioni, i concetti che vi si contemplano: vi è un unico pensiero o assillo o cruccio che li genera, li sostanzia e sommuove. In altri termini avrei eliminato i titoli dei testi onde favorire lo sviluppo continuativo del discorso poetico, così sempre scosso dal timore-tremore e dal singulto, dal la- mento della creatura umana. Indifesa incerta inquieta smarrita e interrogante e implorante al cospetto della problematicità del tempo, che possiede una sua segreta e dilemmatica ascesa metafisica; il tempo, che scorrendo so- vrasta la creatura della terra sino a mutarne la realtà terrena e a risucchiarla nel mistero di una realtà “altra” posta nella dimensione dell’Ignoto ovvero del Tempo di Dio.
Tutta la raccolta è in bilico tra l’angoscia-tensione e la grazia agostiniana (cfr. Presenza, grazia), le stesse che muovono la ricerca di Dio in Agostino: basterà leggere questi versi di Giudice per rendersene conto: “Ricordo / il tempo in cui smarrito / affranto / ti chiedevo / Signore, cove sei? / (…) ti sottraevi al mio assillo / al mio penare / negavi / il tuo fievole bisbiglio”. Ebbene, “fievole”, molto fievole è invece il nostro bisbiglio di uomini smarriti. Meglio: il nostro bisbiglio; il chiasso, il frastuono umano, il pascoliano rumore da bugno vuoto, nel quale si consuma il dramma della Storia, come sopraffazione e violenza. Il Suo bisbiglio, invece, lo stiamo ancora aspettando. Stiamo ancora aspet- tando un Suo cenno, un Suo pur vago segnale!
Di queste attese, di questi contrasti, di queste contraddizioni, di queste tensioni, di questi timori e trepidazioni e angosce è fatta la poesia di Emanuele, intrisa della speranza “paziente sul limite del tempo”. Una speranza che rischia la scommessa col tempo (Giudice ha amato la scommessa, anche in politica) non è che di-speranza che attende di perdere il suo prefisso privativo per divenire speranza piena. Bene, questa la poesia di Emanuele Giudice: il passo dolente dell’uomo che scandisce il dolore della terra. E’ l’uomo che identificandosi nel dolore del mondo si fa protagonista in questa poesia della contemplazione speranzosa del dolore terreno, lo stigma che da sempre connota la specie umana, particolarmente nella grandiosità e nella miseria (ancora l’ossimoro!) dell’approccio col momento estremo del “finale d’avventura”.
Giovanni Occhipinti
|