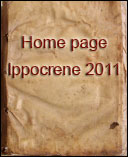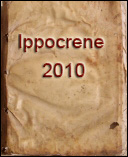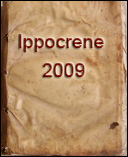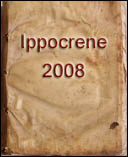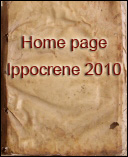|

Ignazio Apolloni ha un amore profondo per la Singlossia però ne ha uno viscerale per le favole (Favole per adulti e Capellino, già pubblicati). Sollecitato da tale ultimo impulso ( e dalla profonda simpatia che meritano sia i diversi sia le minoranze ) ha scritto questo romanzo, in cui una donna diventa simbolo di una condizione dell’essere.
Ne parlerà nel libro che segue, con il distacco che si conviene a un autore che voglia continuare a creare. Sarà aiutato nella sua ricerca umana e stilistica da un flauto magico, come dire il violino di un gigante della poesia – colui che ha popolato i sogni e le fantasie del popolo ebraico da duemila anni a questa parte.
In copertina: Il violinista verde di Marc Chagall, 1923-24. Olio su tela, cm. 198 x 108,6. New York, Solomon R. Guggenheim Museum. Un “caso” l’opera aperta di Ignazio Apolloni Fra i tanti libri di letteratura critica e creativa che vanno sempre più straripando nello scaffale riservato ai “nuovi arrivi”, vorrei oggi segnalare un romanzo decisa¬mente atipico. L’ha scritto Ignazio Apolloni per le edizioni, elegantissime, di Novecento, e s’intitola “Gilberte”.
Era da parecchio che non avevo notizie di Apolloni, inesauribile sperimentatore di creatività multimediali, sempre all’insegna della provocazione, del gioco, del favolistico (ricordo per esempio “Favole per adulti” e “Capellino”), e di tutto quanto è letteralmente sorprendente. A quest’amore profondo per la sperimentazione permanente Apolloni ha dato un nome: “singlossia” (unione espressiva di più lingue, o, cedendogli direttamente la parola, “complementarità di due o più linguaggi tradizionalmente autonomi”), termine che - ricordo - circolava, abbastanza insistentemente, e in antitesi polemica da parte dell’Apolloni, al’interno dell’ “antigruppo” siciliano, assai attivo negli Anni Settanta, cui del resto Apolloni, anche se con voce spesso discorde, diede un notevole contributo d’idee insieme ai vari Pietro Terminelli, Rolando Certa, Santo Calì, ecc. ecc.; il contributo di Apolloni si segnava (e tuttora si segna) sempre per originalità creativa, provocazione, fantasiosità.
Ed eccomi ora di fronte a questo libro(ne) composito, dal tono essenzialmente diaristico, in cui luoghi e persone s’inseguono senza sosta e dove una donna, sorta di archetipo rovesciato, diventa simbolo d’una condizione dell’essere odierno. Chi è in effetti Gilberte? È una giovane donna di vaga ascendenza ebraica che il narratore (Montefeltro: fotografo e scrittore) sta per lasciare definitivamente dopo anni passati a incantarsi l’uno dell’altra, e a incantarsi, entrambi, di Parigi. Questo lo spunto di partenza dal quale con febbrile movimento a catena i due si trovano e ritrovano in molteplici luoghi europei alla ricerca di una “memoria ancestrale” nella quale ritrovare un’identità pacificata con se stessa. Ecco allora che il “viaggio” diventa anche un andare a ritroso nel tempo e nello spazio, alla conquista di una dimensione per così dire virginale in cui la volontà irriducibile si rimescola continuamente al senso di ambiguità (da intendersi nel significato migliore del suo etimo), e laddove vengono costantemente poste interrogazioni fondamentali sull’esistere e l’emigrare, sul diventare e il ritornare.
Il tutto, come a dipanare e ad avvolgere una matassa di forte spessore metaforico di cui si perde e si ritrova il capo, con alcune folgorazioni indimenticabili, tipo questa sul pittore Amedeo Modigliani: “Amedeo Modigliani non giunse a Parigi spinto dal bisogno di diventare artista. Voleva trovarvi il siero della vita, il mantello della storia oppure il cicaleccio intraducibile di una miriade di formiche intente solo a costruire sentieri pedonali. Gli scarabocchi da lui lasciati sui quaderni, quasi mai utilizzati per scriverci pensieri compiuti, sembrano tessiture elastiche, trame di viaggi senza apparente ritorno”.
Romanzo di grande forza visionaria e poetica - tanto che se la critica italiana non fosse ahimé spesso settaria e distratta si potrebbe perfino parlare di questo libro come “caso” letterario - “Gilberte” è, e resta, “opera aperta”, perché, accompagnato simbolicamente dal violino di Chagall, con essa, come ha sottolineato lo stesso Apolloni, “si annulla l’autore e si costringe il lettore a farsi parte creatrice”. Luigi Fontanella
|