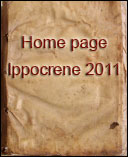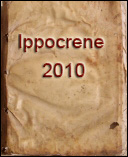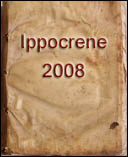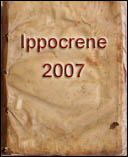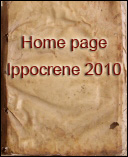| CONVERSAZIONE CON MARIA ATTANASIO - di ELISA MANDARA' |
|
Conversazione con Maria Attanasio «Romanzo non vuol dire bugia. Spesso la vita è più imbrogliona di un romanzo». Paolo Ciulla, udienza del 23-10-1923
Il falsario di Caltagirone (Sellerio, 2007), romanzo saldamente legato al documento storico, offre l’occasione di una conversazione con l’autrice sulla dialettica tra verità e invenzione nella narrativa. Riguardo al proprio rapporto con la storia, Maria Attanasio racconta di essere cresciuta con la politica: «Dopo una lunga militanza politica», confessa l’autrice, «ho quasi avvertito un senso di colpa per la mia attività letteraria, che ho potuto superare grazie ai temi e alle modalità specifiche della mia scrittura, consistenti essenzialmente in un corpo a corpo col presente e con la vita, che attuo recuperando spesso il passato, la memoria. Nella poesia uso la metafora, nella narrazione ricorro alla vita che è già stata, che mi dà una forza speciale per affrontare il presente». Chiedendole di modelli e stelle fisse, l’autrice lega la propria passione per la cronaca storica agli esempi alti di Manzoni, di Marguerite Yourcerar, di Stendhal, di Sciascia». In ciò la prima traccia di sicilianità dell’autrice, data «la forte presenza, in Sicilia, del romanzo storico e la centralità, in esso, di luogo e memoria»; la Attanasio trasceglie le piccole esistenze, ossia la microstoria, per le quali si avvicina alla pagina grande della storia e, attraverso questa, al presente. Si comprende come il passato si faccia allora possibile interlocutore del presente: «Sciascia sosteneva che il fascismo non è una febbre transitoria: come il nazismo, come i genocidi può ritornare», continua l’autrice, che, in una illustrazione immaginifica della propria ispirazione, racconta di quanto la tocchino le esistenze oscurate, la latenza di vissuto, fino ad esercitare una pressione sul presente: «a volte mi capita di leggere una cronologia o un diario, e di incontrare un personaggio che ‘bussa’ dentro di me, alla mia testa e alle mie emozioni, e allora io lo devo raccontare ‘per forza’. Tutti i miei personaggi sono veri, realmente esistiti nel tempo e nello spazio. Paolo Ciulla rimanda alla mia infanzia: in caso di disagio economico, a Catania e Caltagirone, lo si invocava. Conoscevo il mito, non il personaggio; l’ho cercato e, trovandolo, ho scoperto la storia della Sicilia, che si schiude divergente dall’immagine lampedusiana di immobilismo: se sono innegabili, nel passato insulare, lo scialle nero e il feudo, ciò non esaurisce la nostra storia: fortissima, anche a Ragusa, la presenza anarchica, la vitalità delle idee, e questo aspetto di norma si tace. In Sicilia c’è stata la storia del divenire, non solo della staticità, ci sono stati i Fasci siciliani, ossia la prima lotta di classe dell’Italia intera, c’è stato un modello amministrativo dialogante col socialismo (De Felice municipalizzò anche i forni – a Catania ci fu il pane proletario –, mentre a Caltagirone operò Luigi Sturzo). Dunque sicuramente siciliana, Maria Attanasio, pur scansando, però, il rischio di annegare in uno schema di scuola o corrente: è una insularità eidetica, la sua, di repertorio di suggestioni ancestrali, di profumi e occorrenze cromatiche, più che di modi. Immediato, per esempio, l’accostamento a Consolo, per il similare uso del documento. Ma la nota risultante è altra: lontana dallo sperimentalismo barocco consoliano, la Attanasio persegue la trasparenza espressiva, che bilancia del resto le arditezze della propria produzione lirica. A chi è profano del processo creativo balena la curiosità sulla mobilità dell’ispirazione, che in un autore pago dei consensi larghi di critica e pubblico quale la Attanasio, viaggia tra poesia e prosa. Le si chiede se sia la materia a provocare la scelta della forma, lirica o narrativa, del testo, e come avvenga il passaggio tra le due esperienze. Si chiacchiera sulla libertà assoluta della poesia e su quella condizionata di un romanzo che attinge al vero, sul regalo di essenzialità, di sinteticità della poesia alla prosa, sui registri non dicotomici, dunque, delle forme tante dell’arte. Su un passato sicilianamente avvertito come metafora del presente e come emporio creativo di possibilità di vita, caricato, con vis polemica e costruttiva, della bruciante urgenza dell’oggi.
|
| Pros. > |
|---|